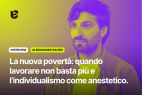A cura di Claudia Pace.
Ho iniziato a lavorare nel 2016, firmando il mio primo contratto durante l’estate. Come ogni persona neolaureata che si rispetti all’inizio avevo aspettative altissime nei confronti del mondo del lavoro, o ancora meglio, del mondo della creatività.
Durante il percorso universitario ero arrivata a una sorta di compromesso tra intenzioni e possibilità: inizialmente la passione nei confronti dell’arte materica mi aveva spinto a iscrivermi al corso di laurea in Scenografia, che contava una media di 10 alunni iscritti ad annata (vorrei ben vedere, visto il numero di teatri attivi in Italia… ) ma poco prima dell’inizio chiesi il trasferimento al corso di Direzione Artistica e Grafica. Bisogna essere pragmatici: se non si è benestanti di famiglia e si vuole puntare a una indipendenza economica in tempi brevi non si può passare il tempo a costruire capitelli in gesso o dipingere a olio su tele di 3 metri nella speranza di rientrare in un mercato piccolissimo e privilegiato.
La promessa fatta a me stessa di mantenere un taglio creativo e originale ha dovuto fare i conti con la realtà del mestiere nelle agenzie pubblicitarie e la necessità di “rispondere alle richieste del mercato”, ma da persona autistica quale ho scoperto di essere, sono rimasta congelata davanti al mio primo contratto.
Il ruolo per il quale ero stata scelta era quello di “Art Director” in una grande agenzia di comunicazione milanese, ma il contratto faceva riferimento a un CCNL molto lontano dal mio quotidiano: la metalmeccanica. Ricordo lo stupore, la perplessità, il tipico rigetto neuro divergente verso l’idea di firmare qualcosa in cui non credo veramente seppur relativamente innocua. Non avrei saldato né fuso dei metalli, perché dovevo firmarlo? Ok, non succedeva niente, mi avrebbero pagato ugualmente, ma perché?
Diversi ex colleghi di quel periodo mi tranquillizzarono: era tutelante, uno dei migliori per il settore. Tuttavia, queste considerazioni non risolvevano i miei dubbi sui quali andava concentrandosi il mio rimuginio.
C'è qualcosa di profondamente poetico nel dover spiegare a tua madre, dipendente pubblico, che di mestiere "creai contenuti e strategie digitali per ottimizzare l'engagement sui social media" mentre il tuo contratto potrebbe identificarti come "addetto alla vendita" o “operaio metallurgico”. Non è Kafka, è l'Italia del lavoro creativo nel 2025.
Benvenuti nel surreale mondo della comunicazione italiana, dove i contratti sono come i vestiti vintage: belli da vedere in vetrina, ma quando li indossi scopri che sono stati pensati per persone di un'altra epoca, con altre misure e soprattutto per altri mestieri, nonostante i recenti aggiornamenti come quello del Commercio al 2025.
Benvenuti nel luogo dove l’ignavia si diffonde più velocemente delle malattie sessualmente
trasmissibili e dove si preferisce lamentarsi del divorzio del Ferragnez o dedicarsi alla ricerca di un inutilissimo Labubu sold out ma nessuno ha più voglia di pretendere salari, orari, contratti e diritti adeguati nel luogo in cui trascorriamo più di otto ore al giorno.
Siccome come il vecchio Giorgio credo che “libertà è partecipazione” e non stare sopra un albero, ho deciso di cercare e approfondire alcuni dei contratti più comuni nel settore per mettere alla luce alcune delle assurdità sulle quali quotidianamente mettiamo la firma.
Il Commercio: l'arte di vendere aria fritta
Il contratto del commercio è l'equivalente lavorativo di un coltellino svizzero cinese: promette di fare tutto, ma quando lo usi davvero si spezza in mano. È il prediletto delle agenzie creative perché offre quella flessibilità che permette di chiamarti alle 23:00 di domenica per "un piccolo ritocco urgente al video, tanto ci metti cinque minuti".
Per far fronte alle “variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda”, infatti, può superare l’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Teoricamente, “a fronte della presentazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati” una pari entità di ore di riduzione. Praticamente, non avviene mai.
Quanto straordinario può essere chiesto? “Fino al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate”. Se, ad esempio, hai un contratto da 40 ore, questo significa che legalmente puoi arrivare a lavorarne 54.
Attenzione, però: “il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare qualora giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”.
Ora, secondo voi, motivazioni come “vorrei passare un po’ di tempo con mio figlio o con il mio partner, visto che il lavoro mi impegna già 8 ore al giorno e altre 2 le passo in viaggio” valgono come esigenza familiare comprovata? Oppure “vorrei andare in palestra, perché già passo 10 ore al giorno seduto”?
Tra l’altro, chi crede davvero ai fantomatici periodi di minore intensità lavorativa, se le aziende non hanno neppure l’obbligo di riconoscere un compenso aggiuntivo? La leva del sovrapprezzo economico, infatti, svanisce del tutto: “i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale”.
E touché: scopriamo che l’unica flessibilità desiderabile è quella che ti permette, se tutto va bene, di toccarti i piedi facendo yoga.
Avremmo poi una maggiorazione dello stipendio in caso di lavoro straordinario standard: fino alla 48ª ora settimanale è previsto un incremento del 15%, oltre la 48ª del 20%. Per il lavoro festivo o domenicale la maggiorazione sale al 30%, mentre per il notturno arriva al 50%. Ma con tutta questa flessibilità, chi stabilisce davvero cosa sia straordinario e cosa no?
La bellezza di questo contratto è che ti consente di lavorare nei fine settimana perché “l’attività commerciale lo richiede”, anche se la tua “attività commerciale” consiste nel progettare loghi per gare appena vinte, non nel gestire il Black Friday da Unieuro. Ma tant’è: se il cliente decide che vuole la campagna pronta per lunedì, tu il sabato e la domenica sei operativo e la gita al lago può tranquillamente saltare.
Certo, in questo contratto vediamo: tredicesima e quattordicesima, congedo matrimoniale di 15 giorni retribuiti al 100% (tralasciando l’esclusività e il privilegio sociale impliciti in questo beneficio: il costo medio di un matrimonio in Italia si aggira comunque sui 25.000 euro complessivi). A questo si aggiunge il congedo parentale di 10 mesi per ciascun genitore, fruibili entro i primi 12 anni di vita del figlio, retribuiti però solo al 30% per i primi 6 mesi e del tutto non retribuiti per i successivi (come se crescere un bambino non comportasse ulteriori spese). Ma siamo davvero sicuri che il gioco valga la candela? Per chiunque volesse approfondire lascio dei link qui, qui e qui.
Il Metalmeccanico: quando photoshop diventa un tornio
Il contratto metalmeccanico applicato alla comunicazione è l’equivalente di montare un motore Ferrari su una Panda: sulla carta sembra un’idea geniale, poi ti accorgi che fai più rumore che strada. È il contratto dei paradossi, quello che ti paga (un po’) meglio di altri, salvo trattarti come se passassi le tue giornate a forgiare bulloni incandescenti invece di litigare con il cliente che alle 22:30 ti scrive “lo vorrei più wow”.
Le aziende lo scelgono perché è un contratto robusto, antico, strutturato: ti dà scatti di anzianità che sembrano usciti da un film di Ermanno Olmi, con un solenne riconoscimento del fatto che, più invecchi davanti al monitor, più il tuo stipendio sale di qualche euro e sicuramente non abbastanza per restare al passo con l’inflazione. Nobile intento, per carità, se non fosse che l’anzianità spesso coincide con il progressivo appassimento del tuo entusiasmo creativo sotto scadenze impossibili e la necessità di formazione continua.
Sulla carta, è la colonna portante del contratto: “Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua”. Ti immagini corsi fighissimi di motion graphics, intelligenza artificiale applicata alla creatività, o workshop su come sopravvivere alle notti in bianco passate a correggere le virgole di un piano editoriale. Invece, nella pratica, le “ultime novità” possono essere corsi di utensili CNC, perché il contratto nasce per chi produce pezzi di metallo, o anche corsi da titoli accattivanti ma tenuti dal migliore amico del tuo capo, appassionato di linguaggio inclusivo per il quale il rosa è un “colore da donne” e rappresenta dolcezza e affetto per questa ragione.
Questa formazione dovrebbe aiutarti a colmare il gap delle competenze digitali e a costruire la tua identità digitale, come sancito nel Verbale di Intesa del 12 luglio 2018. Peccato che la tua identità digitale sia messa meglio di quella dei tuoi superiori, e il tuo vero problema sia evitare di impazzire quando il cliente ti dice: “Per lunedì rendilo più emozionante, ma senza cambiare niente”.
La parte più surreale è proprio l’inquadramento: ufficialmente, vieni considerato un lavoratore a rischio di ustioni da metallo fuso, quando nella realtà i tuoi pericoli sono la sindrome del tunnel carpale da mouse e l’esaurimento nervoso da project management schizofrenico. Se poi finisci in trasferta, il contratto ti tutela con rimborsi puntuali e indennità di trasferta forfettarie per pasto e pernottamento. E, se lavori in alta montagna o in sottosuolo (cosa molto probabile per un copywriter), ti spetta pure un 10% in più.
Ma attenti, a quanto ammontano queste indennità secondo il CCNL?
Alzi la mano chi, in trasferta a Milano, riesce a pernottare con 20,53 euro per 3 mesi, prenotando il viaggio con 7 giorni di anticipo in quanto “Le aziende sono tenute a comunicare al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi.”
Sulla carta, la macchina contrattuale è perfetta: tutela, scatti di anzianità, rimborsi chilometrici, corsi di aggiornamento. Ma se provi ad applicare questa stessa struttura a chi lavora nella comunicazione e ai costi del 2025, ti ritrovi a vivere un esperimento di ingegneria contrattuale un po’ grottesco.
Prendi ad esempio le pari opportunità: se l’azienda supera i 1000 dipendenti, si istituisce una Commissione paritetica per le pari opportunità con la missione di promuovere comportamenti coerenti con i principi di uguaglianza, prevenire molestie e facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo la maternità. Sono principi sacrosanti e necessari, ma calati nel contesto delle agenzie di comunicazione, coinvolte di recente nel Me too, la loro applicazione diventa un altro dei tanti pezzi di un puzzle normativo ma mai verificate veramente.
E che dire del periodo di prova? Anche qui, il contratto prevede regole di una precisione quasi notarile: se hai già fatto apprendistato nello stesso ruolo per almeno due anni, puoi avere un periodo di prova ridotto. Ma alla
fine, l’unico documento che conta davvero è la lettera di assunzione, che fa “testo” e decreta quanti mesi dovrai passare con il fiato sospeso sperando che nessuno decida di interrompere tutto per un imprevisto o uno straordinario rifiutato.
La gestione del tempo è un altro capitolo surreale. Nei contratti a tempo parziale, si possono prevedere clausole elastiche e flessibili che consentono di cambiare orario o di aumentare la durata della prestazione lavorativa, previo preavviso di 7 giorni e con adeguate maggiorazioni (il 10% o il 15%, a seconda dei casi). Una premura che però mal si concilia con la realtà del lavoro creativo, dove la flessibilità vera si misura in ore di straordinari non pagati e in urgenze che fioccano ogni cinque minuti.
Se poi superi i limiti annui di ore supplementari, la maggiorazione passa dal 10% al 20%. Anche qui, uno scrupolo di precisione burocratica che stride con le maratone notturne passate a editare presentazioni e grafiche che “devono uscire domani mattina”.
In sintesi, applicare il contratto metalmeccanico alla realtà creativa è come pretendere di smontare e rimontare un’identità di brand con lo stesso cacciavite con cui monteresti un braccio meccanico.
Funziona, sì, ma con una discreta dose di surreale. E la sensazione costante che la Panda, con sotto il motore Ferrari, alla fine vada un po’ a scatti.
Anche qui, per chiunque voglia approfondire può farlo a questo link.
Il Grafico Editoriale: nostalgia canaglia per un'era che non esiste più
Questo contratto è come un disco di vinile: affascinante per gli appassionati, ma sostanzialmente inadeguato ai tempi. È nato quando "grafico" significava impaginare giornali con forbici e colla, non creare story Instagram per influencer che vendono integratori miracolosi ed è stato aggiornato nel 2025 da chi forse i social non li ha neanche mai visti.
Ti fa sentire parte di una tradizione artigianale nobile, salvo poi scoprire che quella tradizione è stata spazzata via dalla rivoluzione digitale e tu sei rimasto con un contratto che non contempla nemmeno l'esistenza di internet. Le aziende lo scelgono perché costa poco e suona professionale. "Abbiamo assunto un grafico editoriale" fa molto più serio di "abbiamo preso uno che sa usare Canva". Il problema è che mentre il titolo suona vintage chic, lo stipendio è vintage miseria.
Dentro ci finisce un po’ di tutto. Il contratto si occupa, almeno “sulla carta” (lol) di cose che vanno dalla progettazione grafica fino all’assistenza online per la clientela, passando per ogni passaggio immaginabile del processo produttivo editoriale. Si parte con la progettazione vera e propria, poi si passa alla riproduzione di testi e immagini, che deve essere rigorosamente indipendente dal supporto finale, come se bastasse scriverlo per essere automaticamente competenti tanto nella serigrafia quanto in una newsletter responsive. Poi ci sono le operazioni di prestampa, che suonano come un rituale arcano tra montaggi e matrici, un po’ come entrare in un tempio della grafica anni '80. E quando finalmente si stampa, con qualsiasi tecnica disponibile, dall’offset alla flessografia, dalla calcografia alla stampa digitale, ci si prepara all’allestimento e alla legatoria, perché l’odore della colla vinilica è ancora considerato sacro.
Ma non finisce lì: qui dentro rientra anche l’editoria in tutte le sue varianti, dai libri ai periodici generalisti, fino a quelli specializzati, scientifici, tecnici, culturali, come se fossero tutti sullo stesso piano, come se realizzare un saggio di medicina e un settimanale di gossip fosse la stessa cosa e richiedesse la stessa cultura e formazione. C’è spazio anche per l’editoria digitale e multimediale, che viene buttata lì come un’aggiunta d’obbligo. Per chiudere il cerchio, ci sono anche la gestione sistemistica degli apparati tecnologici, qualunque cosa voglia dire, e l’informazione o assistenza online.
A rendere tutto ancora più interessante è la questione della carta. Il contratto si lancia in una riflessione tecnica sul rapporto tra fatturato e premi di produzione, spiegando con tono serio che, data l’alta incidenza del costo della carta e i suoi sbalzi di prezzo, è opportuno depurare il fatturato dal suo valore. Lodevole intento, almeno sulla teoria.
Poi arriva il grande capitolo dello straordinario, dove si manifesta il lato elastico, o se vogliamo, gommato, di questo contratto. Lo straordinario esiste, certo, ma ha una forma tutta sua. Tecnicamente è tutto ciò che va oltre il normale orario settimanale, ma se si applica la flessibilità o la multiperiodicità (che già da sola suona come una materia di fisica teorica), allora bisogna fare i conti a consuntivo, cioè quando tutto è già accaduto e non c’è più molto da discutere. In teoria il limite massimo è di 250 ore all’anno, che sembrano tante ma non abbastanza per placare l’appetito di fiere, mostre, allestimenti, emergenze produttive, prototipi da costruire all’alba o turni improvvisati per evitare danni catastrofici.
In tutti questi casi, e i casi sono talmente tanti che diventano la regola, le ore extra non contano nel monte ore massimo. Una finta barriera, insomma. E se ti stai chiedendo dove finiscono queste ore, la risposta è semplice: possono confluire tutte, al 100%, nella Banca delle ore. Che, a seconda di come la vedi, può sembrare un bel modo per gestire il tempo o solo una cassaforte dove depositi stanchezza sperando di poterla ritirareprima che il burnout ti bussi alla porta.
Infine c’è la questione del riposo settimanale, che di base dovrebbe cadere di domenica, ma può essere spostato per esigenze religiose o organizzative, con la solita clausola: “se l’azienda è d’accordo”. Nel testo si legge “Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse, e solo se le esigenze organizzative lo permettano, può beneficiare di un riposo settimanale” quindi se non sei straniero ma sei musulmano, sono fatti tuoi.
Il diritto al riposo compensativo, almeno quello, resta. Forse non è molto, ma è pur sempre
qualcosa a cui aggrapparsi mentre si cerca di tradurre questo contratto antico in una lingua che oggi somiglia sempre più a quella di un algoritmo. Se vuoi approfondire, puoi farlo qui.
La matematica dell'assurdo
I numeri raccontano una storia tragicomica: in un settore dove la creatività dovrebbe essere la risorsa più preziosa, ci ritroviamo con differenze salariali che non hanno nulla a che vedere con le competenze, ma dipendono unicamente dal contratto che ti è capitato in sorte.
Un po’ come se Michelangelo fosse stato pagato in modo diverso a seconda che impugnasse uno scalpello da muratore o da orefice, come se il genio potesse essere tariffato in base al catalogo dell’utensileria.
E mentre ti illudi che almeno uno di questi contratti riesca a raccontare il tuo lavoro per ciò che è, scopri che nessuno, davvero nessuno, rispecchia il quotidiano di chi crea contenuti, progetti grafici o strategie digitali. Nove aziende su dieci nel settore della comunicazione si arrangiano con contratti concepiti per tutt’altri mestieri. Come se tutti i ristoranti italiani
applicassero contratti pensati per meccanici, parrucchieri o venditori di enciclopedie porta a porta. Funziona? Tecnicamente sì, nel senso che la carta è firmata e lo stipendio, prima o poi, arriva. Ma ha senso? Assolutamente no.
La vera ironia è che lavoriamo in un settore che ha rivoluzionato il modo di comunicare, di vendere e persino di pensare, eppure, nel diritto del lavoro italiano, praticamente non esistiamo. Siamo i ghost writer della legislazione contrattuale: creiamo valore, generiamo fatturato, influenziamo mercati interi, ma sulla carta siamo trasparenti.
Il settore della comunicazione è enorme: solo le agenzie di marketing sono circa 18.000, ma contando anche web marketing, media company e studi di comunicazione, si superano le 40.000 imprese attive. Complessivamente, tra aziende e professionisti, si arriva a una forza lavoro di 150-200 mila persone (tante quante gli abitanti di Padova).
Il valore economico è impressionante: il mercato della comunicazione in Italia vale quasi 13 miliardi di euro, di cui il 70% viene dai media tradizionali e il restante 30% dall’Experiential Market, che cresce a ritmi importanti. Solo nel 2024, gli investimenti in digital ADV hanno superato i 5,5 miliardi di euro.
Eppure, nonostante tutto questo movimento e queste cifre, l’Italia investe meno della metà rispetto alla media dei paesi avanzati in comunicazione e marketing, lasciando in gran parte inutilizzate le enormi opportunità del settore offerte dal PNRR. Il paese che ha inventato il Rinascimento, oggi si comporta come se il digitale fosse una moda passeggera. Mentre altri paesi europei hanno creato categorie contrattuali specifiche per UX designer, social media manager, content creator e digital strategist, noi continuiamo a ficcare tutto nel calderone del commercio. Questa è la realtà di chi lavora in un mondo in fermento, ma che ancora deve vedersi riconosciuto un contratto degno della sua importanza.
Il problema non è solo economico, ma profondamente culturale. Ogni prodotto che compri, ogni servizio che usi, ogni azienda che conosci ha dietro qualcuno che ha creato la sua immagine, ha pensato alla sua comunicazione, ha ideato le sue campagne. Ma tutte queste persone sono contrattualmente inquadrate come se facessero tutt'altro.
Finché continueremo a incastrare professioni nate nel futuro dentro contratti del passato scritti da chi non li capisce, resteremo bloccati in questo limbo tragicomico dove la creatività viene lodata a parole ma sottopagata nei fatti. Forse è ora di smettere di vestirci con costumi non adatti e iniziare a pretendere un abito professionale cucito su misura.
Nel frattempo, toccherà ancora spiegare ai nostri genitori che sì, facciamo un lavoro vero, anche se il contratto ci definisce venditori di aspirapolvere. La prossima volta quindi che qualcuno ti dirà “tanto è tutto uguale”, ricordargli che anche i vestiti sembrano tutti uguali finché non li indossi.