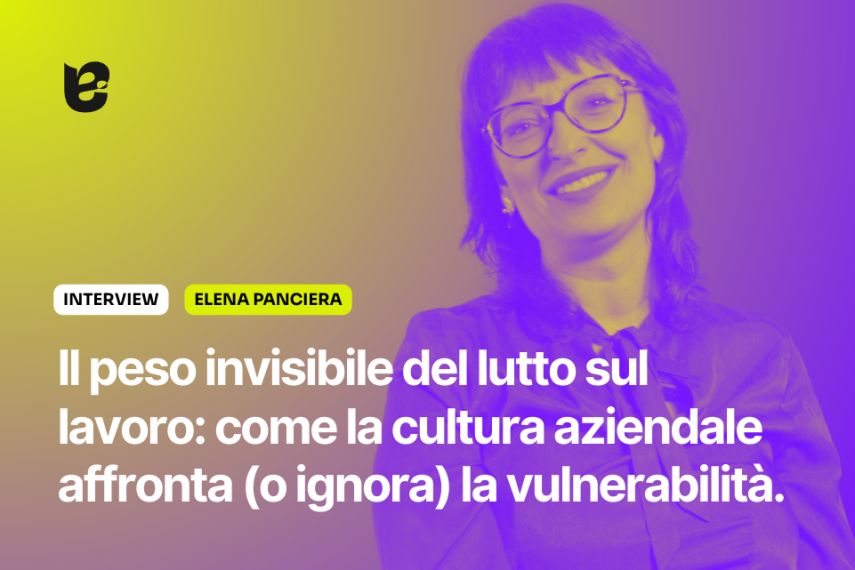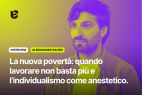In alcune culture, il lutto è una pratica condivisa, quasi pubblica: in Messico il Día de los Muertos celebra i defunti con altari e colori, in Giappone i riti funebri coinvolgono la comunità con momenti di ascolto e sostegno reciproco. Queste tradizioni rendono il dolore visibile e riconosciuto. In Italia, invece, la morte spesso si trasforma in un silenzio improvviso: poche parole di circostanza, un funerale, e poi la vita, e il lavoro, devono continuare come se nulla fosse cambiato.
Il lutto non si misura solo in giorni di assenza. Chi perde una persona cara spesso deve fare i conti con un impatto profondo sulla propria vita lavorativa: calo di concentrazione, stanchezza cronica, difficoltà a prendere decisioni.
Secondo uno studio della European Agency for Safety and Health at Work, il 35% dei lavoratori che hanno subito un lutto riferisce di un peggioramento del benessere psicologico e un aumento dello stress sul lavoro sul lungo periodo.
La cultura aziendale italiana raramente riconosce questi effetti.
In molti contesti, il ritorno al lavoro coincide con la necessità di “tornare normali”, di non mostrare vulnerabilità, di rispettare ritmi e obiettivi come se nulla fosse accaduto.
Questo silenzio aggiunge ulteriore dolore, isolando chi ha bisogno di tempo e di supporto psicologico.
La difficoltà di parlare di morte
Non è solo una questione di numeri o di giorni di permesso: è anche linguistica e culturale. La morte resta un tabù, e il modo in cui ne parliamo lo conferma.
Evitiamo la parola stessa: diciamo che una persona “è andata via”, “ci ha lasciati”, “non c’è più”. Sono considerate espressioni cordiali, che di fatto creano distanza e impediscono di confrontarsi davvero con il dolore.
Questo linguaggio ha conseguenze concrete: chi non riesce a nominare il lutto fatica anche a chiedere supporto, e chi ascolta può sentirsi disarmato.
Normalizzare il dialogo sulla morte è quindi un passo fondamentale per offrire spazi di sostegno reali, sia nella vita privata che in quella professionale.
Integrare vulnerabilità e consapevolezza
Affrontare la morte significa anche ripensare il modo in cui integriamo vulnerabilità e consapevolezza nella vita quotidiana. Il lutto non è solo una perdita da “superare”: è un’esperienza che può insegnare resilienza, empatia e profondità di relazione.
Le aziende hanno qui un ruolo chiave. Non si tratta di “mettere in scena” la sensibilità o di creare momenti simbolici: significa creare policy concrete per il supporto psicologico, spazi di ascolto, flessibilità reale per chi sta elaborando un lutto. Significa accogliere il dolore senza giudizio, riconoscendo che anche nel lavoro le persone hanno bisogno di tempo e strumenti per elaborare le proprie perdite.
Verso una cultura che accoglie il lutto
Riconoscere la morte come parte della vita non è semplice, soprattutto in un contesto dove la produttività e l’efficienza sono spesso priorità assolute. Ma la consapevolezza del lutto e la capacità di parlarne rappresentano un investimento di valore: persone sostenute emotivamente sono più resilienti, più partecipi e più autentiche nel loro lavoro.
Creare una cultura che accoglie la vulnerabilità significa anche abbattere un tabù secolare, restituire dignità a chi soffre e offrire strumenti concreti per elaborare la perdita. Non si tratta di sentimentalismo, ma di salute mentale concreta, di attenzione al benessere dei lavoratori e, di riflesso, di migliori risultati per le organizzazioni.
👉 Guarda l’intervista completa a Elena Panciera e scopri la sua testimonianza